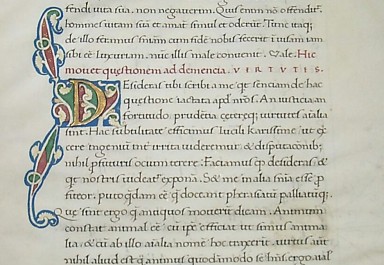
Lucio Anneo Seneca, figlio di Seneca il Padre o il Retore, nacque a Cordoba (Spagna) probabilmente attorno al 4 a.C. ma si trasferì ben presto a Roma per ricevere istruzione. Nell'Urbe segue lezioni di retorica e di filosofia stoica e neopitagorica, soprattutto con il maestro Sozione; è da queste correnti filosofiche che derivano il rigore morale e le abitudini austere dell'autore. Si pensi infatti che l'autore latino rifiutava di lavarsi con l'acqua calda perché lo riteneva segno di mollezza e che inaugurava l'avvento dell'anno nuovo con una nuotata nel Tevere.
Nel 26 d.C. si reca in Egitto per motivi di salute (per poter godere della calura); tornato a Roma comincia il cursus honorum assumendo la carica di questore. Diviene oratore brillante ma si scontrerà però con l'imperatore Claudio, la cui moglie Messalina l'aveva accusato di adulterio con Giulia Livilla, sorella di Caligola. Per questo dal 41 a.C. sarà esiliato in Corsica fino al 49 a.C., quando verrà richiamato da Agrippina, seconda moglie di Claudio e sorella di Giulia Livilla.
In seguito, Claudio lo sceglie come precettore del figlio di Nerone che, guidato anche da Afranio Burro e dalla madre, sembra apprendere con successo gli insegnamenti: l'obiettivo di Seneca era quello di formare un imperatore modello. Nel 54 d.C. Claudio muore e il diciottenne Nerone prende su di sé la carica di imperatore: in realtà in questo periodo sono sua madre, Seneca e Afranio Burro ad avere la reggenza. I rapporti di Nerone con la madre entrano però in crisi, e per questo l'imperatore, in accordo con Seneca, ne ordina l'assassinio. Il filosofo rimarrà al fianco di Nerone fino al 62 d.C., quando, dopo essersi liberato di Afranio (sostituito da Tigellino) e della madre, si ritira a vita privata (secessus). È in questa fase della sua vita che raggiunge quella vita contemplativa da lui sempre tanto lodata in passato e in cui produce molte delle sue opere maggiori.
Nel 65 d.C. viene accusato di aver partecipato alla congiura dei Pisoni contro Nerone, il quale per questo, gli ordinò di uccidersi. Tacito ci narra la morte del filosofo: deciso a tagliarsi le vene, compie il gesto davanti agli amici, discorrendo di filosofia. Prima effettua il taglio, poi chiude la ferita per far uscire il sangue lentamente e in fin di vita si fa immergere in una vasca d'acqua calda. Nerone muore tre anni dopo, nel 68 d.C..
Il De brevitatae vitae si colloca all'interno dei Dialogi: opera in 12 libri in cui l'autore parla in prima persona, rivolgendosi ad un tu dedicatario di cui si immaginano possibili domande alle quali l'autore risponde. Inevitabile è il confronto con i Dialogi di Cicerone, dove, al contrario di quelli senecani, vi era un'ambientazione storica, un fattore drammatico e la presenza di più personaggi che interagiscono.
Il De brevitate vitae fu scritto per l'amico Paolino nel 49 d.C., al rientro dell'autore dall'esilio. Il tema principale è espresso nella seguente sententia: vita, si uti scias, longa est (ovvero, la vita, se la sai usare, è lunga). Egli si scaglia contro gli indaffarati che non si accorgono di vivere ed esalta la vita contemplativa tipica invece della figura del saggio che impiega correttamente il suo tempo nell'unica attività veramente degna: la ricerca della verità e della saggezza. È in quest'opera sostenuto il principio dell'auterkeia, l'autosufficienza, l'indipendenza da cose il cui possesso non dipende da noi e dunque la libertà da ogni condizionamento esteriore. Questa critica agli occupati potrebbe indurre a pensare che il pensiero di Seneca sia in linea con quello epicureo, ma non è così: egli sostiene che si debba vivere giorno per giorno ma sempre pensando che potrebbe essere l'ultimo.
Molti non sanno usare il tempo
| Latino | Italiano |
| XII. [1] Quaeris fortasse quos occupatos
uocem? Non est quod me solos putes dicere quos a basilica immissi demum
canes eiciunt, quos aut in sua uides turba speciosius elidi aut in
aliena contemptius, quos officia domibus suis euocant ut alienis foribus
illidant, [aut] hasta praetoris infami lucro et quandoque suppuraturo
exercet. [2] Quorundam otium occupatum est: in uilla aut in lecto suo,
in media solitudine, quamuis ab omnibus recesserint, sibi ipsi molesti
sunt: quorum non otiosa uita dicenda est sed desidiosa occupatio. Illum
tu otiosum uocas qui Corinthia, paucorum furore pretiosa, anxia
subtilitate concinnat et maiorem dierum partem in aeruginosis lamellis
consumit? qui in ceromate (nam, pro facinus! ne Romanis quidem uitiis
laboramus) spectator puerorum rixantium sedet? qui iumentorum suorum
greges in aetatum et colorum paria diducit ? qui athletas nouissimos
pascit? [3] Quid? Illos otiosos uocas quibus apud tonsorem multae horae
transmittuntur, dum decerpitur si quid proxima nocte succreuit, dum de
singulis capillis in consilium itur, dum aut disiecta coma restituitur
aut deficiens hinc atque illinc in frontem compellitur? Quomodo
irascuntur, si tonsor paulo neglegentior fuit, tamquam uirum tonderet!
Quomodo excandescunt si quid ex iuba sua decisum est, si quid extra
ordinem iacuit, nisi omnia in anulos suos reciderunt! Quis est istorum
qui non malit rem publicam turbari quam comam suam? qui non sollicitior
sit de capitis sui decore quam de salute? qui non comptior esse malit
quam honestior? Hos tu otiosos uocas inter pectinem speculumque
occupatos? [4] Quid illi qui in componendis, audiendis, discendis
canticis operati sunt, dum uocem, cuius rectum cursum natura et optimum
et simplicissimum fecit, in flexus modulationis inertissimae torquent,
quorum digiti aliquod intra se carmen metientes semper sonant, quorum,
cum ad res serias, etiam saepe tristes adhibiti sunt, exauditur tacita
modulatio? Non habent isti otium, sed iners negotium. [5] Conuiuia me
hercules horum non posuerim inter uacantia tempora, cum uideam quam
solliciti argentum ordinent, quam diligenter exoletorum suorum tunicas
succingant, quam suspensi sint quomodo aper a coco exeat, qua celeritate
signo dato glabri ad ministeria discurrant, quanta arte scindantur aues
in frusta non enormia, quam curiose infelices pueruli ebriorum sputa
detergeant: ex his elegantiae lautitiaeque fama captatur et usque eo in
omnes uitae secessus mala sua illos sequuntur, ut nec bibant sine
ambitione nec edant. [6] Ne illos quidem inter otiosos numeraueris qui
sella se et lectica huc et illuc ferunt et ad gestationum suarum, quasi
deserere illas non liceat, horas occurrunt, quos quando lauari debeant,
quando natare, quando cenare alius admonet: [et] usque eo nimio delicati
animi languore soluuntur, ut per se scire non possint an esuriant. [7]
Audio quendam ex delicatis (si modo deliciae uocandae sunt uitam et
consuetudinem humanam dediscere), cum ex balneo inter manus elatus et in
sella positus esset, dixisse interrogando: "Iam sedeo?" Hunc tu
ignorantem an sedeat putas scire an uiuat, an uideat, an otiosus sit?
Non facile dixerim utrum magis miserear, si hoc ignorauit an si ignorare
se finxit. [8] Multarum quidem rerum obliuionem sentiunt, sed multarum
et imitantur; quaedam uitia illos quasi felicitatis argumenta delectant;
nimis humilis et contempti hominis uidetur scire quid facias: i nunc et
mimos multa mentiri ad exprobrandam luxuriam puta. Plura me hercules
praetereunt quam fingunt et tanta incredibilium uitiorum copia ingenioso
in hoc unum saeculo processit, ut iam mimorum arguere possimus
neglegentiam. Esse aliquem qui usque eo deliciis interierit ut an sedeat
alteri credat! [9] Non est ergo hic otiosus, aliud illi nomen imponas;
aeger est, immo mortuus est; ille otiosus est cui otii sui et sensus
est. Hic uero semiuiuus, cui ad intellegendos corporis sui habitus
indice opus est, quomodo potest hic ullius temporis dominus esse? [...] XIII. [1] Persequi singulos longum est quorum aut latrunculi aut pila aut excoquendi in sole corporis cura consumpsere uitam. Non sunt otiosi quorum uoluptates multum negotii habent. Nam de illis nemo dubitabit quin operose nihil agant, qui litterarum inutilium studiis detinentur, quae iam apud Romanos quoque magna manus est. |
XII. [1] Chiedi forse chi io definisco affaccendati?
Non pensare che io bolli come tali solo quelli che soltanto cani aizzati
riescono a cacciar fuori dalla basilica, quelli che vedi esser
stritolati o con maggior lustro nella propria folla o più
vergognosamente il quella altrui, quelli che gli impegni spingono fuori
dalle proprie case per schiacciarli con gli affari altrui, o che l'asta
del pretore fa travagliare con un guadagno disonorevole e destinato un
giorno ad incancrenire. [2] Il tempo libero di alcuni è tutto impegnato:
nella loro villa o nel loro letto, nel bel mezzo della solitudine,
benché si siano isolat da tutti, sono fastidiosi a se stessi: la loro
non deve definirsi una vita sfaccendata ma un inoperoso affaccendarsi.
Puoi chiamare sfaccendato chi dispone in ordine con minuziosa pignoleria
bronzi di Corinto, pregiati per la passione di pochi, e spreca la
maggior parte dei giorni tra laminette rugginose? Chi in palestra
(infatti, che orrore!, neppur romani sono i vizi di cui soffriamo) siede
come spettatore di ragazzi che lottano? Chi divide le mandrie dei propri
giumenti in coppie di uguale età e colore? Chi nutre gli atleti (giunti)
ultimi? [3] E che? Chiami sfaccendati quelli che passano molte ore dal
barbiere, mentre si estirpa qualcosa che spuntò nell'ultima notte,
mentre si tiene un consulto su ogni singolo capello, mentre o si rimette
a posto la chioma in disordine o si sistema sulla fronte da ambo i lati
quella rada? Come si arrabbiano se il barbiere è stato un po'
disattento, come se tosasse un uomo! Come si irritano se viene tagliato
qualcosa dalla loro criniera, se qualcosa è stato mal acconciato, se
tutto non ricade in anelli perfetti! Chi di costoro non preferisce che
sia in disordine lo Stato piuttosto che la propria chioma? Che non sia
più preoccupato della grazia della sua testa che della sua incolumità?
Che non preferisca essere più elegante che dignitoso? Questi tu
definisci sfaccendati, affaccendati tra il pettine e lo specchio? [4] Quelli
che sono dediti a comporre, sentire ed imparare canzoni, mentre torcono
in modulazioni di ritmo molto modesto la voce, di cui la natura rese il
corretto cammino il migliore e il più semplice, le cui dita cadenzanti
suonano sempre qualche carme dentro di sé, e di cui si ode il silenzioso
ritmo quando si rivolgono a cose serie e spesso anche tristi? Costoro
non hanno tempo libero, ma occupazioni oziose. [5] Di certo non annovererei
i banchetti di costoro tra il tempo libero, quando vedo con quanta
premura dispongono l'argenteria, con quanta cura sistemano le tuniche
dei loro amasi, quanto siano
trepidanti per come il cinghiale vien fuori dalle mani del cuoco, con
quanta sollecitudine i glabri accorrono ai loro servigi ad un dato
segnale, con quanta maestria vengano tagliati gli uccelli in pezzi non
irregolari, con quanto zelo infelici fanciulli detergano gli sputi degli
ubriachi: da essi si cerca fama di eleganza e di lusso e a tal punto li
seguono le loro aberrazioni in ogni recesso della vita, che non bevono
né mangiano senza ostentazione. [6] Neppure annovererai tra gli sfaccendati
coloro che vanno in giro sulla portantina o sulla lettiga e si
presentano all'ora delle loro passeggiate come se non gli fosse permesso
rinunziarvi, e che un altro deve avvertire quando si devono lavare,
quando devono nuotare o cenare: e a tal punto illanguidiscono in troppa
fiacchezza di un animo delicato, da non potersi accorgere da soli se
hanno fame. [7] Sento che uno di questi delicati - se pure si può chiamare
delicatezza il disimparare la vita e la consuetudine umana - ,
trasportato a mano dal bagno e sistemato su una portantina, abbia detto
chiedendo: "Sono già seduto?". Tu reputi che costui che ignora se sta
seduto sappia se è vivo, se vede e se è sfaccendato? Non è facile dire
se mi fa più pena se non lo sapeva o se fingeva di non saperlo.
[8] Certamente di molte cose soffrono in realtà la dimenticanza, ma di molte
anche la simulano; alcuni vizi li allettano come oggetto di felicità;
sembra che il sapere cosa fai sia tipico dell'uomo umile e disprezzato;
ora va e credi che i mimi inventano molte cose per biasimare il lusso.
Certo trascurano più di quanto rappresentano ed è apparsa tanta
abbondanza di vizi incredibili in questo solo secolo, che ormai possiamo
dimostrare la trascuratezza dei mimi. Vi è qualcuno che si consuma a tal
punto nelle raffinatezze da credere ad un altro se è seduto! [9] Dunque
costui non è sfaccendato, dagli un altro nome: è malato, anzi è morto;
sfaccendato è quello che è consapevole del suo tempo libero. Ma questo
semivivo, a cui è necessaria una spia che gli faccia capire lo stato del
suo corpo, come può costui essere padrone di alcun momento? [...] XIII. [1] Sarebbe lungo enumerare uno ad uno coloro la cui vita consumarono gli scacchi o la palla o la cura del corpo con il sole. Non sono sfaccendati quelli i cui piaceri costano molta fatica.. Infatti di essi nessuno dubiterà che non fanno nulla con fatica, che si tengono occupati in studi di inutili opere letterarie, le quali ormai anche presso i Romani sono un cospicuo numero. |
De brevitate vitae, 12 (1-7), 13 (1)
In questo passo Seneca ci dipinge la figura dell'affaccendato, una
specie di antitesi del saggio, un uomo legato alle cose terrene, un giorno
"destinate ad incancrenire", che si dedica ad ozi in maniera maniacale ("oziose
occupazioni"), capace anche nella pace di una villa di campagna di essere
occupato, tanto da diventare "fastidioso a sé stesso". Tra costoro enumera
collezionisti, allenatori di giovinetti, narcisisti, cantori e letterati:
persone che per le loro faccende hanno "disimparato a vivere e la consuetudine
romana", alcuni arrivano a chiedere allo schiavo "sono già seduto?" e a farsi
indicare a che ora mangiare. Essi non sono neppure padroni del proprio corpo,
non sono "padroni di alcun momento", sono malati, anzi già morti.
Seneca in questo passo ci descrive con maestria "l'impietoso spettacolo
dell'alienazione umana" (A. Traina) tramite la figura dell'occupato,
colui che si preoccupa
di tutto tranne che di sé stesso, continuamente indaffarato non si ferma mai per
dedicarsi alla ricerca della saggezza, arrivando così a sprecare la propria vita
in faccende inutili. L'intento è proprio di esortare ad evitare che questo
accada, a non perdere la propria essenza di uomo con inutili occupazioni che
arrivano ad alienarci, trasformandoci in esseri non più consci di nulla, neppure
del tempo, che in breve ci porterà, per via dell'avvicinarsi della morte, ad
esclamare "è breve la vita!", se tale possiamo definirla.
Fermenti esistenzialisti in Seneca
| Latino | Italiano |
| III. [1] Omnia licet quae umquam ingenia fulserunt in hoc unum consentiant, numquam satis hanc humanarum mentium caliginem mirabuntur: praedia sua occupari a nullo patiuntur et, si exigua contentio est de modo finium, ad lapides et arma discurrunt; in uitam suam incedere alios sinunt, immo uero ipsi etiam possessores eius futuros inducunt; nemo inuenitur qui pecuniam suam diuidere uelit, uitam unusquisque quam multis distribuit! Adstricti sunt in continendo patrimonio, simul ad iacturam temporis uentum est, profusissimi in eo cuius unius honesta auaritia est. [2] Libet itaque ex seniorum turba comprendere aliquem: "Peruenisse te ad ultimum aetatis humanae uidemus, centesimus tibi uel supra premitur annus: agedum, ad computationem aetatem tuam reuoca. Duc quantum ex isto tempore creditor, quantum amica, quantum rex, quantum cliens abstulerit, quantum lis uxoria, quantum seruorum coercitio, quantum officiosa per urbem discursatio; adice morbos quos manu fecimus, adice quod et sine usu iacuit: uidebis te pauciores annos habere quam numeras. [3] Repete memoria tecum quando certus consilii fueris, quotus quisque dies ut destinaueras recesserit, quando tibi usus tui fuerit, quando in statu suo uultus, quando animus intrepidus, quid tibi in tam longo aeuo facti operis sit, quam multi uitam tuam diripuerint te non sentiente quid perderes, quantum uanus dolor, stulta laetitia, auida cupiditas, blanda conuersatio abstulerit, quam exiguum tibi de tuo relictum sit: intelleges te immaturum mori." | III. [1] Per quanto siano concordi su questo solo punto gli ingegni più illustri che mai rifulsero, mai abbastanza si meraviglieranno di questo appannamento delle menti umane: non tollerano che i propri campi vengano occupati da nessuno e, se sorge una pur minima disputa sulla modalità dei confini, si precipitano alle pietre ed alle armi: permettono che altri invadano la propria vita, anzi essi stessi vi fanno entrare i suoi futuri padroni; non si trova nessuno che sia disposto a dividere il proprio denaro: a quanti ciascuno distribuisce la propria vita! Sono avari nel tenere i beni; appena si giunge alla perdita di tempo, diventano molto prodighi in quell’unica cosa in cui l’avarizia è un pregio. [2] E così piace citare uno dalla folla degli anziani: "Vediamo che sei arrivato al termine della vita umana, hai su di te cento o più anni: suvvia, fa un bilancio della tua vita. Calcola quanto da questo tempo hanno sottratto i creditori, quanto le donne, quanto i patroni, quanto i clienti, quanto i litigi con tua moglie, quanto i castighi dei servi, quanto le visite di dovere attraverso la città; aggiungi le malattie, che ci siamo procurati con le nostre mani, aggiungi il tempo che giacque inutilizzato: vedrai che hai meno anni di quanti ne conti. [3] Ritorna con la mente a quando sei stato fermo in un proposito, quanti pochi giorni si sono svolti così come li avevi programmati, a quando hai avuto la disponibilità di te stesso, a quando il tuo volto non ha mutato espressione, a quando il tuo animo è stato coraggioso, che cosa di positivo hai realizzato in un periodo tanto lungo, quanti hanno depredato la tua vita mentre non ti accorgevi di cosa stavi perdendo, quanto ne ha sottratto un vano dispiacere, una stupida gioia, un'avida bramosia, una piacevole discussione, quanto poco ti è rimasto del tuo: capirai che muori anzitempo". |
De brevitate vitae, 3 (1-3)
I critici sono d'accordo nel definire questo passo riguardante il tempo uno dei
maggiori momenti della speculazione filosofica di Seneca.
Secondo Traina la riflessione di Seneca, dopo quella sul rapporto uomo-cosmo di
Lucrezio e quella uomo-società di Cicerone, si concentra sulla relazione
dell'uomo con la sua interiorità. Interiorità che, secondo Bacci, precorre gli
esistenzialisti con i quali condivide il metodo asistematico e la nozione di
"noia" radicale descritta da Heidegger. Quest'ultimo sostenne infatti che quella
che noi viviamo a contatto con gli altri e con il mondo è esistenza banale,
che ci spersonalizza e ci trasforma in uno dei tanti; stare in mezzo alla folla
significa disperdere sé stessi nel mondo, e dunque alienarsi. Evidente è
l'analogia con il passo sopra, in cui patroni, creditori e donne invadono la
vita, sottraggono tempo e la "disponibilità di te stesso". Ciò, secondo Seneca,
ci porta a vivere un'esistenza vuota conducendo fino a "immaturum mori" (morire
prima del tempo).
Heidegger parla poi di esistenza autentica, quella che viviamo nella
nostra interiorità, rifiutando gli altri e il mondo e rientrando in sé stessi.
Anche questo tema è presente nel De brevitate vitae, anzi è Seneca il
primo a bandire il messaggio "rientra in te stesso" che sarà poi di Heidegger ma
prima ancora di Agostino e che infine si trasformerà in un "l'Inferno sono gli
altri" con Sartre. Spesso infatti troviamo negli scritti di Seneca esempi di
vita autentica, quella del saggio, che non cade nella banalità del quotidiano e
si sviluppa negli ampi spazi dell'animo alla ricerca della saggezza, lontano
dalla folla spersonalizzante, inquinante e alienante.
Le Epistuale ad Lucilium sono 124 lettere suddivise in 20 libri indirizzate a Lucilio Iuniorem. Composte tra il 62 e il 65 d.C. sono l'opera filosofica più matura di Seneca: in essa egli appare come un uomo di età avanzata che, abbandonata l'attività politica, finalmente padrone del suo tempo si dedica alla riflessione su temi morali e alla ricerca della saggezza. Il dedicatario, Lucilio, era procuratore in Sicilia, funzionario dell'impero e amico di Seneca ma non è in realtà l'unico dedicatario: l'opera è stata infatti scritta con il preciso intento della pubblicazione poiché, come lo stesso autore ci dice, il suo obiettivo era quello di giovare al maggior numero di persone. Per questo motivo l'epistolario è molto curato (letterarietà): lo stile è pulito, controllato, elevato, ricco di stilemi proprie della tradizione letteraria ma anche di immagini legate alla realtà quotidiana.
La forma utilizzata è quella del sermo, il discorso, la conversazione pacata e serena con amici. Gli argomenti trattati sono vari e l'unico tema portante che si può individuare è al massimo quello del progresso di Lucilio sul cammino filosofico. Per seguire questa evoluzione, Seneca si serve della forma dell'epistolario informale, particolarmente adatto per un approccio dottrinale.
Differenze rispetto al passato
Tra le fonti delle Epistualae morales ad Lucilium bisogna certamente includere Cicerone ed Epicuro, ma con le dovute precisazioni: Cicerone trattava nelle sue lettere di avvenimenti recenti riguardanti l'attualità politica, fatti a dire di Seneca del tutto secondari, mentre Epicuro intendeva esporre una dottrina filosofica vera e propria mentre l'autore di Cordoba si limita ad enunciare una serie di principi morali.
I temi
- Il tempo, uno dei temi più ricorrenti (già trattato nel De brevitate vitae);
- L'insensatezza della vita senza l'amore per la sapienza;
- Compiti e partizioni della filosofia;
- La ricerca del Sommo Bene, che si attua attraverso un
itinerario:
- ricerca della tranquillità della vita;
- dominio delle passioni;
- distacco delle ricchezze;:
- sprezzo della morte;
- Il suicidio;
- La coerenza fra fatti e parole;
- Gli affetti umani;
- La ricerca della solitudine;
- Il linguaggio dei sapienti;
- La vita quotidiana;
- Il rapporto tra servo e padrone;
- Il progresso;
L'opera è in sintesi un invito all'otium, al secessus (separazione dall'attività politica), alla ricerca della sapienza che conduce alla virtù e allontana dalle passioni. Seneca manifesta la sua adesione allo stoicismo con spunti epicurei.
Stile
L'autore si rivolge in prima persona ad un interlocutore, quasi fittizio con uno stile colloquiale, a volte ipotizzando e rispondendo a domande che Lucilio potrebbe porre. Per Seneca le parole non devono dilettare ma giovare (non delectent verba nostram sed prosint), tuttavia è sua intenzione attirare il pubblico e per questo fa uso di artifici retorici, come domande retoriche, sententiae (frasi brevi ma incisive e con grande carica semantica). Caratteristiche dello stile di Seneca sono l'uso della paratassi, della frantumazione, dell'antitesi, del parallelismo, dell'omoteleuto e dell'anafora.
I "veri" schiavi
| Latino | Italiano |
| [10] Vis tu cogitare istum quem servum tuum
vocas ex isdem seminibus ortum eodem frui caelo,
aeque spirare, aeque vivere, aeque mori! tam tu
illum videre ingenuum potes quam ille te servum.
Variana clade multos splendidissime natos,
senatorium per militiam auspicantes gradum,
fortuna depressit: alium ex illis pastorem,
alium custodem casae fecit. Contemne nunc eius
fortunae hominem in quam transire dum contemnis
potes. [11] Nolo in ingentem me locum immittere et de usu servorum disputare, in quos superbissimi, crudelissimi, contumeliosissimi sumus. Haec tamen praecepti mei summa est: sic cum inferiore vivas quemadmodum tecum superiorem velis vivere. Quotiens in mentem venerit quantum tibi in servum <tuum> liceat, veniat in mentem tantundem in te domino tuo licere. [12] 'At ego' inquis 'nullum habeo dominum.' Bona aetas est: forsitan habebis. Nescis qua aetate Hecuba servire coeperit, qua Croesus, qua Darei mater, qua Platon, qua Diogenes? [13] Vive cum servo clementer, comiter quoque, et in sermonem illum admitte et in consilium et in convictum. Hoc loco acclamabit mihi tota manus delicatorum 'nihil hac re humilius, nihil turpius'. Hos ego eosdem deprehendam alienorum servorum osculantes manum. [14] Ne illud quidem videtis, quam omnem invidiam maiores nostri dominis, omnem contumeliam servis detraxerint? Dominum patrem familiae appellaverunt, servos - quod etiam in mimis adhuc durat - familiares; instituerunt diem festum, non quo solo cum servis domini vescerentur, sed quo utique; honores illis in domo gerere, ius dicere permiserunt et domum pusillam rem publicam esse iudicaverunt. [15] 'Quid ergo? omnes servos admovebo mensae meae?' Non magis quam omnes liberos. Erras si existimas me quosdam quasi sordidioris operae reiecturum, ut puta illum mulionem et illum bubulcum. Non ministeriis illos aestimabo sed moribus: sibi quisque dat mores, ministeria casus assignat. Quidam cenent tecum quia digni sunt, quidam ut sint; si quid enim in illis ex sordida conversatione servile est, honestiorum convictus excutiet. [16] Non est, mi Lucili, quod amicum tantum in foro et in curia quaeras: si diligenter attenderis, et domi invenies. Saepe bona materia cessat sine artifice: tempta et experire. Quemadmodum stultus est qui equum empturus non ipsum inspicit sed stratum eius ac frenos, sic stultissimus est qui hominem aut ex veste aut ex condicione, quae vestis modo nobis circumdata est, aestimat. [17] 'Servus est.' Sed fortasse liber animo. 'Servus est.' Hoc illi nocebit? Ostende quis non sit: alius libidini servit, alius avaritiae, alius ambitioni, <omnes spei>, omnes timori. Dabo consularem aniculae servientem, dabo ancillulae divitem, ostendam nobilissimos iuvenes mancipia pantomimorum: nulla servitus turpior est quam voluntaria. Quare non est quod fastidiosi isti te deterreant quominus servis tuis hilarem te praestes et non superbe superiorem: colant potius te quam timeant. [18] Dicet aliquis nunc me vocare ad pilleum servos et dominos de fastigio suo deicere, quod dixi, 'colant potius dominum quam timeant'. 'Ita' inquit 'prorsus? colant tamquam clientes, tamquam salutatores?' Hoc qui dixerit obliviscetur id dominis parum non esse quod deo sat est. Qui colitur, et amatur: non potest amor cum timore misceri. [19] Rectissime ergo facere te iudico quod timeri a servis tuis non vis, quod verborum castigatione uteris: verberibus muta admonentur. Non quidquid nos offendit et laedit; sed ad rabiem cogunt pervenire deliciae, ut quidquid non ex voluntate respondit iram evocet. [20] Regum nobis induimus animos; nam illi quoque obliti et suarum virium et imbecillitas alienae sic excandescunt, sic saeviunt, quasi iniuriam acceperint, a cuius rei periculo illos fortunae suae magnitudo tutissimos praestat. Nec hoc ignorant, sed occasionem nocendi captant querendo; acceperunt iniuriam ut facerent. [21] Diutius te morari nolo; non est enim tibi exhortatione opus. Hoc habent inter cetera boni mores: placent sibi, permanent. Levis est malitia, saepe mutatur, non in melius sed in aliud. Vale. |
[10] Vuoi tu pensare che questo che tu chiami tuo servo
nato dallo stesso seme gode
dello stesso cielo, respira allo stesso modo, vive allo stesso modo, muore allo
stesso! Tanto tu puoi vedere lui libero quanto egli (può vedere) te schiavo.
Con la strage di Varo la sorte umiliò molti di nobilissima nascita che aspiravano attraverso il servizio
militare al grado senatorio: (la sorte) rese uno di quelli pastore, un altro
custode del casolare.
Disprezza ora l'uomo di quella condizione in cui anche tu puoi cadere proprio
mentre la disprezzi. [11] Non voglio addentrarmi in una questione troppo lunga e discutere sul trattamento degli schiavi, nei confronti dei quali siamo assai superbi, assai crudeli, assai offensivi. Tuttavia questa è la sintesi del mio insegnamento: vivi con il tuo inferiore allo stesso modo in cui vorresti che il tuo superiore vivesse con te. Ogni volta che ti verrà in mente quanto potere hai verso il tuo servo, ti venga in mente che il tuo padrone ha lo stesso potere su di te. [12] "Ma io", dici, "non ho nessun padrone". Sei ancora giovane; forse lo avrai. Non sai a che età Ecuba cominciò a essere schiava, a che età Creso, la madre di Dario, Platone, Diogene? [13] Vivi in modo clemente con il servo, anche con dolcezza, e ammettilo alla tua conversazione, alle tue decisioni e alla tua mensa. A questo punto griderà contro di me tutto il manipolo di voluttuosi non c'è nulla di più umile di questa cosa, nulla di più turpe. Io questi stessi li potrei sorprendere mentre baciano la mano dei servi degli altri. [14] E neppure vi rendete conto di come i nostri antenati hanno eliminato ogni invidia verso i padroni e offesa verso gli schiavi? Chiamarono padre di famiglia il padrone e domestici gli schiavi, appellativo che è rimasto nei mimi; stabilirono un giorno festivo, affinché i padroni non mangiassero con i servi solo in quello, ma almeno in quello; concessero loro di occupare posti di responsabilità nell'ambito familiare, di amministrare la giustizia e considerarono la casa un piccolo stato. [15] E dunque? Inviterò alla mia tavola tutti gli schiavi? Non più che tutti gli uomini liberi. Sbagli se pensi che respingerò qualcuno perché esercita un lavoro troppo umile, per esempio quel mulattiere o quel bifolco. Non li giudicherò in base al loro mestiere, ma in base alla loro condotta; della propria condotta ciascuno è responsabile, il mestiere, invece, lo assegna il caso. Alcuni siedano a mensa con te, perché ne sono degni, altri perché lo diventino; se c'è in loro qualche tratto servile derivante dal rapporto con gente umile, la dimestichezza con uomini più nobili lo eliminerà. [16] Non devi, caro Lucilio, cercare gli amici solo nel foro o nel senato: se farai attenzione, lo troverai anche in casa. Spesso un buon materiale rimane inservibile senza un abile artefice: prova a farne esperienza. Allo stesso modo è stupido uno che al momento di comprare un cavallo non lo esamina, ma guarda la sella e le briglie; così è molto stupido chi giudica un uomo dall'abbigliamento e dalla condizione sociale, che ci sta addosso come un vestito. [17] "È un servo". Ma forse libero nell'animo. "È un servo". Questo gli nuocerà? Mostra chi non lo sia: uno è schiavo del piacere, l'altro dell'avarizia, un altro dell'ambizione, tutti della speranza, tutti del timore. Porterò come esempio un console schiavo di una vecchietta, un ricco schiavo di un'ancella, mostrerò giovani assai nobili schiavi di pantomimi: nessuna servitù è più vergognosa di quella volontaria. Perciò non vi è motivo che questi schizzinosi ti distolgano dal mostrarti cordiale con i tuoi schiavi e superiore non in modo superbo: ti rispettino piuttosto che temerti. [18] Qualcuno ora dirà che io chiamo gli schiavi alla rivolta e faccio cadere i padroni dal loro trono, poiché ho detto "rispettino il padrone piuttosto che temerlo". "Dice proprio così (il detto)? Rispettino allo stesso modo dei clienti, dei salutatori?". Chi dicesse questo dimenticherà che ai padroni non è sufficiente ciò che è sufficiente ad un dio. Colui che è rispettato, è anche amato: l'amore non può mescolarsi con il timore. [19] Dunque io penso che tu agisci in modo assai giusto se non vuoi essere temuto dai tuoi servi, se ti servi del castigo delle parole: con le frustate si correggono le bestie. Non tutto ciò che ci colpisce ci fa anche male; ma i piaceri ci spingono a giungere alla rabbia tanto che tutto ciò che non risponde alla nostra volontà provoca la nostra ira. [20] Noi indossiamo l'animo dei re; infatti quelli dimentichi anche delle loro forze e della debolezza altrui vanno così su tutte le furie, infieriscono così come se avessero ricevuto un'offesa, ma dal pericolo di questa la grandezza della loro sorte li mantiene assai sicuri. Né ignorano ciò, ma lamentandosi prendono l'occasione di oltraggiare; hanno ricevuto un'ingiuria per farla. [21] Non voglio trattenerti più a lungo; tu non hai bisogno di consigli, la virtù fra gli altri vantaggi ha (anche) questo: piace a sé stessa, rimane inalterata. Il vizio, invece, è incostante, spesso cambia, non in meglio, ma in altro. Addio. |
Episulae ad Lucilium, libro V, 47 (10-21)
Seneca in questo passo parla della schiavitù e denuncia il maltrattamento nei confronti della servitù da parte dei padroni, che assumono verso di essi un atteggiamento di superiorità. È proprio questa convinzione di superiorità che Seneca intende smontare: egli sostiene l'uguaglianza di schiavo e uomo libero con argomenti carattere genetico ed esistenziale: ogni uomo nasce allo stesso modo, vive allo stesso modo e soprattutto muore allo stesso modo. Egli incita a non deridere la condizione schiavile perché ognuno rischia in ogni momento di incapparvi, infatti è il fato che assegna la condizione sociale ("che ci sta addosso come un vestito") e dunque non dipende da noi. Le persone e gli schiavi in particolare, dunque, vanno valutati per ciò che dipende da loro, dalla loro condotta. "Forse è libero nell'animo", ipotizza, introducendo un altro tipo di libertà, che dipende dalla nostra volontà in tutto e per tutto: la libertà dalle passioni. Immancabili sono a questo punto della discussione gli esempi di cittadini formalmente liberi ma in realtà schiavi, i veri schiavi: un console schiavo di una vecchietta, giovani nobili schiavi di pantomimi e altro. Anzi, è addirittura più turpe questo tipo di schiavitù perché volontaria e non dettata da condizioni contingenti. La conclusione di Seneca è quella di rispettare gli schiavi, così come noi desidereremmo essere rispettati dal nostro padrone.
Questi temi furono già affrontati da altri autori, in particolare da Platone (Repubblica, 577 d) per quanto riguarda la concezione di libertà, non dal punto di vista giuridico uomo libero/schiavo, ma come libertà dalle passioni, sottomesse dalla ragione; Seneca ha anche però debiti verso la filosofia stoica ed epicurea:
| Latino | Italiano |
| Suave, mari magno turbantibus aequora
ventis e terra magnum alterius spectare laborem |
È dolce, mentre i venti sconvolgono i
flutti nel grande mare osservare da terra il travaglio di un altro; |
Lucrezio (filosofo latino epicureo) all'inizio del proemio al secondo libro del De Rerum Naturae esprime, con una splendida metafora quasi del tutto nominale, la condizione del saggio che osserva, distaccato e superiore, l'affannarsi degli uomini, continuamente agitati dalla tempesta delle passioni che egli riesce invece a dominare attraverso atarassia e aponia.
La libertà dell'animo
| Latino | Italiano |
| [7] Non multum ad hoc locus confert nisi se
sibi praestat animus, qui secretum in occupationibus mediis si volet
habebit: at ille qui regioneseligit et otium captat ubique quo
distringatur inveniet. Nam Socraten querenticuidam quod nihil sibi
peregrinationes profuissent respondisse ferunt, 'non inmerito hoc tibi
evenit; tecum enim peregrinabaris'. [8] O quam benecum quibusdam
ageretur, si a se aberrarent! Nunc premunt se ipsi, sollicitant,
corrumpunt, territant. Quid prodest mare traicere et urbes mutare? si
visista quibus urgueris effugere, non aliubi sis oportet sed alius. Puta
venissete Athenas, puta Rhodon; elige arbitrio tuo civitatem: quid ad
rem pertinetquos illa mores habeat? tuos adferes. [9] Divitias iudicabis
bonum: torquebitte paupertas, quod est miserrimum, falsa. Quamvis enim
multum possideas, tamen, quia aliquis plus habet, tanto tibi videris
defici quanto vinceris. Honores iudicabis bonum: male te habebit ille
consul factus, ille etiamrefectus; invidebis quotiens aliquem in fastis
saepius legeris. Tantuserit ambitionis furor ut nemo tibi post te
videatur si aliquis ante tefuerit. [10] Maximum malum iudicabis mortem,
cum <in> illa nihil sitmali nisi quod ante ipsam est, timeri.
Exterrebunt te non tantum periculased suspiciones; vanis semper
agitaberis. Quid enim proderit evasisse tot urbes
Argolicas mediosque fugam tenuisse per hostis? Ipsa pax timores sumministrabit; ne tutis quidem habebitur fides consternatasemel mente, quae ubi consuetudinem pavoris inprovidi fecit, etiam ad tutelamsalutis suae inhabilis est. Non enim vitat sed fugit; magis autem periculispatemus aversi. [...] [13] Quid per se peregrinatio prodesse cuiquam potuit? Non voluptatesilla temperavit, non cupiditates refrenavit, non iras repressit, non indomitosamoris impetus fregit, nulla denique animo mala eduxit. Non iudicium dedit, non discussit errorem, sed ut puerum ignota mirantem ad breve tempus rerumaliqua novitate detinuit. [14] Ceterum inconstantiam mentis, quae maximeaegra est, lacessit, mobiliorem levioremque reddit ipsa iactatio. Itaquequae petierant cupidissime loca cupidius deserunt et avium modo transvolantcitiusque quam venerant abeunt. [15] Peregrinatio notitiam dabit gentium, novas tibi montium formas ostendet, invisitata spatia camporum et inriguasperennibus aquis valles; alicuius fluminis <singularem ponet> sub observationenaturam, sive ut Nilus aestivo incremento tumet, sive ut Tigris eripiturex oculis et acto per occulta cursu integrae magnitudinis redditur, siveut Maeander, poetarum omnium exercitatio et ludus, implicatur crebris anfractibuset saepe in vicinum alveo suo admotus, antequam sibi influat, flectitur:ceterum neque meliorem faciet neque saniorem. [16] Inter studia versandumest et inter auctores sapientiae ut quaesita discamus, nondum inventa quaeramus;sic eximendus animus ex miserrima servitute in libertatem adseritur. Quamdiuquidem nescieris quid fugiendum, quid petendum, quid necessarium, quidsupervacuum, quid iustum, quid iniustum, quid honestum, quid inhonestumsit, non erit hoc peregrinari sed errare. [17] Nullam tibi opem feret istediscursus; peregrinaris enim cum adfectibus tuis et mala te tua sequuntur. Utinam quidem sequerentur! Longius abessent: nunc fers illa, non ducis. Itaque ubique te premunt et paribus incommodis urunt. Medicina aegro, nonregio quaerenda est. [18] Fregit aliquis crus aut extorsit articulum: nonvehiculum navemque conscendit, sed advocat medicum ut fracta pars iungatur, ut luxata in locum reponatur. Quid ergo? animum tot locis fractum et extortumcredis locorum mutatione posse sanari? Maius est istud malum quam ut gestationecuretur. [19] Peregrinatio non facit medicum, non oratorem; nulla ars locodiscitur: quid ergo? sapientia, ars omnium maxima, in itinere colligitur? Nullum est, mihi crede, iter quod te extra cupiditates, extra iras, extrametus sistat; aut si quod esset, agmine facto gens illuc humana pergeret. Tamdiu ista urguebunt mala macerabuntque per terras ac maria vagum quamdiumalorum gestaveris causas. [20] Fugam tibi non prodesse miraris? tecumsunt quae fugis. Te igitur emenda, onera tibi detrahe et [emenda] desideriaintra salutarem modum contine; omnem ex animo erade nequitiam. Si vis peregrinationeshabere iucundas, comitem tuum sana. Haerebit tibi avaritia quamdiu avarosordidoque convixeris; haerebit tumor quamdiu superbo conversaberis; numquamsaevitiam in tortoris contubernio pones; incendent libidines tuas adulterorumsodalicia. |
[7] Mi getto a capofitto nello studio. Non è
tanto il luogo che conta per studiare, ma la concentrazione: se uno
vuole, può crearsi un suo spazio anche in mezzo a tutte le occupazioni:
ma chi si limita a scegliersi un posto e a cercare un po' di
tranquillità, troverà dovunque motivi di distrazione. Si racconta che
Socrate, a un tizio che si lagnava di non aver tratto nessun giovamento
dai suoi continui viaggi, rispose: "È logico che ti sia successo questo;
tu andavi in giro con te stesso." [8] Come si troverebbero bene certe
persone se si staccassero da se stesse! E invece si opprimono, si
affliggono, si guastano, si spaventano, tutto da soli. Traversare gli
oceani, cambiare città, cosa serve? Se vuoi liberarti dai tuoi affanni
non devi trasferirti altrove, ma diventare un altro. Fa' conto di essere
andato ad Atene o a Rodi; scegli a tuo piacere la città: che importanza
hanno gli usi e i costumi locali? Tu ci porti i tuoi. [9] Se giudichi un
bene il denaro, ti angustierà una povertà - e questa è la cosa più
triste - falsa. Per quanto tu possieda molto, se c'è uno più ricco di
te, ti sentirai inferiore proprio di quanto lui ha in più. A tuo parere
sono gran cosa le cariche: e allora ti tormenterà che Tizio sia stato
nominato console, che Caio sia stato rieletto; proverai invidia ogni
volta che leggerai ripetutamente il nome di qualcuno negli atti
ufficiali. Il furore della tua ambizione sarà così violento che non ti
parrà di avere nessuno dietro di te, se hai qualcuno davanti a te. [10]
Giudicherai la morte il peggiore dei mali, mentre in realtà nella morte
non c'è nulla di male, se non appunto ciò che la precede, il timore. Ti
spaventeranno non i pericoli, ma piuttosto i sospetti; sarai sempre
agitato da vani fantasmi. E allora che vantaggio ti avrà dato
essere riusciti a scampare a tante città argoliche, essere riusciti a
fuggire in mezzo ai nemici? La pace stessa scatenerà le tue paure; una volta che la mente è turbata, non ci si fida più neppure di ciò che è sicuro, e quando questi timori infondati diventano un'abitudine, non si è più in grado di tutelare se stessi: i pericoli non li evitiamo, li fuggiamo, e se uno gira le spalle, è più vulnerabile. [...] [13] Un viaggio, di per sé, che giovamento ha mai potuto dare? Non modera i piaceri, non frena le passioni, non reprime l'ira, non fiacca gli indomabili impulsi dell'amore, insomma non libera l'anima da nessun male. Non rende assennati, non dissipa l'errore, ma ci attrae temporaneamente con qualche novità come un bambino che ammiri cose sconosciute. [14] Rende, invece, lo spirito, già gravemente infermo, ancora più incostante, e questo agitarsi lo fa diventare più instabile e volubile. E così gli uomini abbandonano con più smania quei posti che avevano tanto smaniosamente cercato, li oltrepassano a volo e se ne vanno più velocemente di quanto erano venuti. [15] Viaggiare ti farà conoscere altre genti, ti mostrerà monti di forme mai viste, pianure di straordinaria grandezza e valli irrigate da corsi d'acqua perenni; attirerà la tua attenzione sulla natura particolare di qualche fiume, come il Nilo che d'estate è gonfio di acque, o come il Tigri che scompare alla vista e, dopo aver percorso un tratto sottoterra, ritorna in tutta la sua grandezza, o come il Meandro, piacevole palestra di tutti i poeti, che si avvolge su se stesso con un corso sempre tortuoso, e spesso, quando è vicino al suo alveo, devia, prima di affluire nelle proprie acque: ma non ti renderà migliore né più assennato. [16] Dobbiamo applicarci allo studio e avere familiarità coi maestri di saggezza per imparare i frutti delle loro ricerche e ricercare le verità non ancora scoperte. Così, sottraendo l'animo alla più misera schiavitù, si rivendica la propria libertà. Ma fino a quando ignorerai che cosa si deve fuggire, che cosa ricercare, che cosa è necessario o superfluo, giusto o ingiusto, questo non sarà viaggiare, ma vagabondare. [17] Correre qua e là non ti servirà a niente: tu vai in giro con le tue passioni, e i tuoi mali ti seguono. E almeno ti seguissero! Sarebbero abbastanza lontani: e invece, non li precedi, li porti con te. Perciò ti assillano dovunque e ti bruciano con la stessa intensità. [18] Il malato deve cercare la medicina adatta, non un nuovo paese. Uno si è rotto una gamba o si è provocato una distorsione: non sale su una carrozza o su una nave, ma chiama il medico, perché gli riduca la frattura o gli sistemi la lussazione. E allora? Secondo te, cambiando paese, puoi guarire un'anima che ha subìto tante fratture e distorsioni? Questo male è troppo grave per curarlo con una passeggiata in vettura. [19] Viaggiare non rende medici o oratori; non c'è scienza che si impari da un luogo: e dunque? La saggezza, la più importante di tutte le scienze, si può forse acquisire in viaggio? Non c'è via, credimi, che ti porti fuori dalle passioni, dall'ira, dalla paura; oppure, se ci fosse, l'umanità vi si dirigerebbe in massa. Questi mali ti incalzeranno e ti tormenteranno nei tuoi vagabondaggi per terra e per mare finché ne porterai con te le cause. [20] Ti stupisci che fuggire non ti serva? I mali che fuggi sono in te. Correggiti, dunque, liberati dai pesi che porti, e contieni i tuoi desideri entro limiti convenienti; estirpa dall'anima ogni malvagità. Se vuoi fare dei viaggi piacevoli, guarisci chi ti accompagna. L'avarizia ti resterà attaccata addosso, finché vivrai insieme a un avaro taccagno; e così l'orgoglio, finché frequenterai un superbo; non ti libererai della tua crudeltà, se stai con un carnefice; l'amicizia degli adulteri infiammerà la tua libidine. |
Episulae ad Lucilium, libro V, 104 (7-10, 13-20)
Il tema, come accade spesso nelle opere di Seneca, è stimolato da un fatto
personale dell'autore: il trasferimento dalla città al suo podere di campagna,
in relazione al quale riporta le sue riflessioni all'amico Lucilio.
Anche in questo passo torna il tema dell'alienazione: gli indaffarati
(onnipresente oggetto delle invettive dell'autore) sono continuamente protesi
verso un futuro che non gli appartiene e che li pone in un perenne stato di
displicentia sui (scontentezza di sé). A questo stato d'animo gli occupati
reagiscono tramite continui spostamenti, ma "un viaggio, di per sé, che
giovamento ha mai potuto dare?" si chiede Seneca. Pur non negando gli effetti
positivi della conoscenza di nuovi usi e costumi che offre la possibilità di
ampliare i propri orizzonti, oppure della bellezza di emozionarsi di fronte a
spettacoli naturali mai visti prima, Seneca, vuole qui mettere in evidenza come
quello che noi definiamo viaggiare sia in realtà semplicemente un
vagabondare, termine che assume nella concezione filosofica senecana il
significato di fuggire. Ma l'atto di fuggire non determina la soluzione di un
problema, ma è semplicemente un modo per ignorarlo voltandogli le spalle,
aumentando peraltro la propria vulnerabilità. "I mali che fuggi sono con te": di
questo non si rendono conto gli occupati. La paura della morte, l'invidia, e
tutte le nostre passioni ci seguiranno ovunque andremo, aggiornandosi ai luoghi
ed ai costumi locali.
Il viaggio diventa dunque simbolo di qualcosa di più ampio di un semplice
spostamento fisico, potremmo addirittura arrivare a paragonarlo al
divertissement pascaliano, ovvero l'atteggiamento tipico di chi ignora un
problema piuttosto che risolverlo, andando alla ricerca di distrazioni continue.
Questo per Seneca non fa null'altro che mantenerci nello stato della "più misera
schiavitù", annullando la nostra libertà. Ancora una volta la via proposta per
riacquisire sé stessi è la ricerca della saggezza attraverso lo studio della
filosofia unita ad un'intensa volontà di cambiamento ("non devi trasferirti
altrove, ma diventare un altro").
Solo il tempo ci appartiene
| Latino | Italiano |
| [1] Ita fac, mi Lucili: vindica te tibi, et
tempus quod adhuc aut auferebatur aut subripiebatur aut excidebat
collige et serva. Persuade tibi hoc sic esse ut scribo: quaedam tempora
eripiuntur nobis, quaedam subducuntur, quaedam effluunt. Turpissima
tamen est iactura quae per neglegentiam fit. Et si volueris attendere,
magna pars vitae elabitur male agentibus, maxima nihil agentibus, tota
vita aliud agentibus. [2] Quem mihi dabis qui aliquod pretium tempori
ponat, qui diem aestimet, qui intellegat se cotidie mori? In hoc enim
fallimur, quod mortem prospicimus: magna pars eius iam praeterit;
quidquid aetatis retro est mors tenet. Fac ergo, mi Lucili, quod facere
te scribis, omnes horas complectere; sic fiet ut minus ex crastino
pendeas, si hodierno manum inieceris. [3] Dum differtur vita transcurrit.
Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est; in huius rei
unius fugacis ac lubricae possessionem natura nos misit, ex qua expellit
quicumque vult. Et tanta stultitia mortalium est ut quae minima et
vilissima sunt, certe reparabilia, imputari sibi cum impetravere
patiantur, nemo se iudicet quicquam debere qui tempus accepit, cum
interim hoc unum est quod ne gratus quidem potest reddere. [4] Interrogabis fortasse quid ego faciam qui tibi ista praecipio. Fatebor ingenue: quod apud luxuriosum sed diligentem evenit, ratio mihi constat impensae. Non possum dicere nihil perdere, sed quid perdam et quare et quemadmodum dicam; causas paupertatis meae reddam. Sed evenit mihi quod plerisque non suo vitio ad inopiam redactis: omnes ignoscunt, nemo succurrit. [5] Quid ergo est? non puto pauperem cui quantulumcumque superest sat est; tu tamen malo serves tua, et bono tempore incipies. Nam ut visum est maioribus nostris, 'sera parsimonia in fundo est'; non enim tantum minimum in imo sed pessimum remanet. Vale. |
[1] Fa' così, caro Lucilio: rivendica a te
il possesso di te stesso, e il tempo, che finora ti veniva sottratto
apertamente, oppure rubato, oppure ti sfuggiva, raccoglilo e conservalo.
Convinciti che le cose stanno così come ti scrivo: una parte del tempo
ci viene portata via, una parte ci viene rapita furtivamente, una parte
scorre via. La perdita più vergognosa, tuttavia, è quella che avviene
per la nostra negligenza. E se vorrai far bene attenzione, ti accorgerai
che gli uomini sprecano gran parte della vita facendo il male, la
massima parte non facendo nulla, la vita intera facendo altro. [2] Chi mi troverai che fissi un prezzo al tempo, che dia valore a un giorno, che si renda conto di morire ogni giorno? In questo infatti c'inganniamo, che vediamo la morte dinanzi a noi: ma gran parte di essa è già passata, tutto il tempo che abbiamo dietro le spalle lo possiede la morte. Fa' dunque, caro Lucilio, quello che mi scrivi di star facendo: afferra e tieni stretta ogni ora; dipenderai meno dal domani se ti impadronirai saldamente dell'oggi. Mentre rinviamo al futuro, la vita se ne va. [3] Tutto il resto, o Lucilio, appartiene agli altri, solo il tempo è nostro; la natura ci ha dato il possesso di quest'unico bene fuggevole e malsicuro, e da questo possesso ci scaccia chiunque lo voglia. Ma la stoltezza dei mortali è tanto grande che accettano di farsi mettere in conto, se li hanno ottenuti, oggetti insignificanti e di nessun valore, comunque sostituibili con altri, mentre nessuno ritiene di essere debitore di alcunché per aver ricevuto in dono il tempo; eppure questo è l'unico bene che neanche chi è riconoscente può restituire. [4] Forse mi chiederai come mi comporto io che ti do questi consigli. Te lo confesserò schiettamente: faccio come chi è spendaccione ma preciso: tengo i conti delle spese. Non posso dire di non sprecare, ma ti potrei dire quanto spreco e perché e come: ti potrei spiegare i motivi della mia povertà. Mi capita però ciò che capita di solito a chi è caduto in miseria non per colpa sua: tutti lo scusano, nessuno lo aiuta. [5] E allora? Non considero povero l'uomo a cui basta quel poco che gli rimane; preferirei tuttavia che tu facessi tesoro delle cose tue; e comincerai per tempo. Infatti, secondo il parere dei nostri antenati, "è troppo tardi per risparmiare quando si è arrivati alla feccia"; perché la parte che rimane sul fondo non è soltanto la più piccola, ma anche la peggiore. Addio. |
Episulae ad Lucilium, libro I, 1 (1-5)
In apertura alla lettera rivolta all'amico Lucilio, Seneca, entra
immediatamente nel vivo dell'argomento, con un'esortazione: "vindica te tibi"
("rivendica a te il possesso di te stesso"). Questo incipit, se così vogliamo
definirlo nonostante la mancanza di un'introduzione vera e propria, espone fin
da subito il tema delle epistole, ridare il possesso di sé al lettore. Per fare
questo Seneca mette in mostra come i mortali non capiscano il valore del tempo,
superiore a quello di qualunque altro bene ("oggetti insignificanti e di nessun
valore, comunque sostituibili con altri") e permettano che sia loro sottratto da
altri. "La perdita più vergognosa, tuttavia, è quella che avviene per la nostra
negligenza" ammonisce Seneca, ammettendo l'esistenza di fattori contingenti che
determinano il nostro tempo, ma muovendo una forte condanna a coloro che per
loro stessa volontà lo sprecano facendo nulla, oppure facendo il male.
Il tempo è presentato nello stesso momento come fuggevole e malsicuro per il suo
inarrestabile procedere ma anche come unico bene che ci appartiene stabilmente,
aspetto per il quale diviene estremamente prezioso. L'autore ammette di sprecare
del tempo, ma ciò che conta è essere consci del come e del perché: ciò significa
non lasciarsi travolgere dagli eventi, il che implica la necessità di una
riflessione, tema che verrà ampiamente sviluppato in seguito.